Serafini Antichità ha curato le scenografie per una rappresentazione teatrale in grande stile. E’ stata rievocata la Battaglia dei Piani Palentini, con lo spettacolo teatrale “Processo a Carlo D’Angiò”, andato in scena a Carsoli presso piazza Corradino, riportiamo uno stralcio storico relativo al giovane re, alla sua storia e alla Battaglia su cui è ispirata l’azione processuale. Sul palco sotto la regia dell’Avv. Giovanni Alberto Marcangeli dunque è stata rievocata in una aula giudiziaria, tutto il processo al Re. Presidente del Tribunale è statoBrizio Montinaro già presidente del Tribunale di Avezzano e capo della Procura di
La storia:
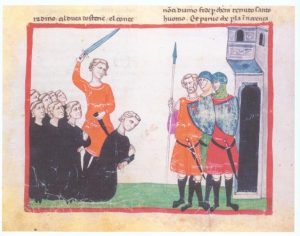 Il 29 ottobre del 1268 il sole splende su Campo del Moricino a Napoli. L’ultimo principe della casa di Svevia lascia Castel dell’Ovo e sale sul patibolo.
Il 29 ottobre del 1268 il sole splende su Campo del Moricino a Napoli. L’ultimo principe della casa di Svevia lascia Castel dell’Ovo e sale sul patibolo.
Sconfitto a Tagliacozzo e catturato con l’inganno, è stato condannato a morte da Carlo d’Angiò.
Prima di essere decapitato si rivolge ai presenti e lancia un guanto alla folla: «Qualcuno raccoglierà la mia sfida». Una mano furtiva raccoglie quel guanto e cova vendetta. Quattordici anni dopo quell’uomo, Giovanni da Procida, già medico di Federico II, si presenta a Pietro d’Aragona e ne invoca l’intervento a favore dei ribelli dei Vespri siciliani.
La discesa in Italia Corradino ha sedici anni quando reclama l’eredità del nonno Federico II e dello zio Manfredi. È cresciuto in Baviera, educato dalla madre Elisabetta di Baviera, tra poeti, racconti epici e spettacoli gentili. Poco conosce della politica e della scena italiana, degli scontri tra guelfi e ghibellini, tra papato e impero. In Italia lo accolgono tutti festosamente, ma quando si tratta di combattere contro Carlo d’Angiò in pochi lo seguono. Anzi, lo tradiscono e lo vendono al rivale.
La calorosa accoglienza ricevuta nella ghibellina Pisa e nelle città imperiali dell’Italia settentrionale incoraggiano Corradino a continuare la marcia verso il Sud e verso l’eredità che legittimamente gli spetta. La rivolta dei guerrieri saraceni di Lucera, ancora fedeli al Falco di Svevia, gli suggerisce la strategia da seguire: puntare sulla città pugliese per liberare la guarnigione dall’assedio e così facendo costringere Carlo alla battaglia. Le cose andranno in maniera molto diversa. Sceso in Italia per riconquistare il regno di Napoli, passato in mani francesi dopo la battaglia di Benevento il 26 febbraio del 1266, Corradino si scontra con le truppe di Carlo d’Angiò nella battaglia di Tagliacozzo, o Scurcola Marsicana, combattuta presso i Piani Palentini il 23 agosto del 1268, e perde tutto.
Corradino scende in Italia passando per il Brennero e il 21 ottobre del 1267 è a Verona. E subito si presentano le prime divisioni. I suoi vassalli tedeschi, tra cui il duca Ludovico, il conte Mainardo e Rodolfo d’Asburgo, consci della situazione italiana, lo consigliano di riprendere la via della Germania, troppo complicato battere l’Angiò e tenere buono il Papa. I nobili italiani, in special modo gli esuli meridionali, lo incitano a proseguire, a puntare a sud, forti anche delle vittorie sul mare e in Sicilia di Corrado Capece. Le notizie provenienti da Lucera e della ribellione dei saraceni fedeli a Federico II, inoltre, convincono Carradino a ripartire alla volta di Pisa con tremila cavalieri, dove entra il 7 aprile del 1268. Nel frattempo papa Clemente IV ha rinnovato la scomunica, privando Corradino del titolo di re di Gerusalemme, predicando la crociata contro il giovane e lanciando l’interdetto alle città che lo avrebbero aiutato. A Roma viene accolto favorevolmente da una piccola parte della nobiltà, con i Frangipane, i Colonna e i Conti che si mantengono neutrali. A questo punto non rimane che lo scontro aperto tra i due rivali.
Corradino e i suoi consiglieri scelgono di non entrare nel Regno attraverso la Via Appia, anche in virtù delle forti posizioni del nemico sulle linee del Liri e del Volturno, ma passando per l’Abruzzo, lungo la Via Valeria avanzando direttamente verso Lucera, dove i saraceni erano insorti dal febbraio. Con cinquemila cavalieri, quindi, lascia Roma e si dirige a sud. La fanteria lo abbandona alle prime difficoltà montuose del percorso, nei pressi di Arsoli. Poco importa, anche re Carlo non ha fanteria.
Tra i due contendenti inizia una partita a scacchi per scegliere il luogo dello scontro. Corradino lascia la Via Valeria e si dirige a nord-est, verso L’Aquila, per evitare la trappola del doppio attraversamento del Salto e di dare battaglia prima del congiungimento con i suoi partigiani di Puglia. Carlo si sposta con i suoi cavalieri sull’altopiano di Ovindoli per intercettare l’avversario. Giunti nella Valle del Salto, gli imperiali si dirigono a Campo Palentino, dove arrivano la sera del 22 agosto. Carlo attraversa la Via Valeria e si attesta ad Albe. In mezzo ai due eserciti scorre un torrente, il Riale, oggi quasi completamente scomparso, che confluisce nel Salto poco più a valle.
Prima della battaglia «Nel 1268 Carlo d’Angiò, riferendo a papa Clemente IV sulla vittoria di Tagliacozzo, accenna prima al suo spostamento “con le schiere formate” e poi a “schiere distinte e ordinate a battaglia” in vista del nemico il quale, a sua volta, lo attende nella pianura antistante “senza tuttavia avere in nessun modo sciolto le sue schiere”». Carlo d’Angiò, però, nella lettera inviata la sera stessa al Papa, per annunciargli la vittoria, non fa cenno al disonorevole trucco utilizzato per ingannare e battere Corradino. Perché sa che la tattica consigliata da Alardo di Valéry e adottata in battaglia viola la consuetudine cavalleresca. Non vi fu onore, d’altronde, nel comportamento del re francese sia nella vendetta contro chiunque avesse aiutato Corradino né nel destino riservato al giovane svevo, nonostante le suppliche di Elisabetta di Baviera, accorsa a Napoli per salvare il figlio.
L’esercito di Corradino era composto da cinquemila cavalieri, superiore a quello del nemico, diviso in tre formazioni schierate lungo il ruscello. Nella prima schiera militavano cavalieri tedeschi, ghibellini toscani ed esuli o rifugiati del Regno, sotto il comando di Kroff di Flünglichen, Corrado di Antiochia e Galvano Lancia. Enrico di Castiglia comandava la seconda schiera di cavalieri spagnoli e ghibellini romani. Corradino e la sua guardia personale, con Federico d’Austria e il marchese Pelavicino erano nella formazione di ghibellini lombardi.
Carlo d’Angiò poteva contare su appena quattromila cavalieri, divisi in tre tronconi: provenzali e guelfi italiani sotto il comando del maresciallo di Francia Henri de Courence; mercenari francesi agli ordini di Jean de Clary e del siniscalco di Provenza Guillaume l’Estendart; la guardia personale del re e i suoi cavalieri più fidati e valorosi. Tra i cavalieri Angioini figurava Alardo di Valéry, il quale aveva passato gli ultimi venti anni della sua vita in Terrasanta, dove aveva appreso un modo diverso di fare la guerra. Non più le violente cariche di cavalleria in campo aperto, ma l’azione di piccoli drappelli di cavalieri, spesso in numero inferiore rispetto al nemico, attraverso agguati e colpi di mano. Così Alardo, vista l’inferiorità numerica dei francesi, consiglia Carlo d’Angiò di nascondere un migliaio di cavalieri dietro un boschetto ai piedi di un colle, sulla destra dello schieramento avversario (“E là da Tagliacozzo/ove senz’armi vinse il vecchio Alardo”, canto XXVIII dell’Inferno). Il piano prevede di attirare gli imperiali in campo aperto, fingere un ripiegamento verso le colline e poi colpirli alle spalle. I francesi hanno preparato un altro inganno per Corradino: il cavaliere Henri de Courence si posiziona al centro della pianura, con la seconda schiera, portando le insegne reali con i gigli della casa di Francia, per attirare e confondere la carica avversaria. I consiglieri di Corradino indicano il centro francese: «Sire, Carlo si è circondato dei suoi cavalieri più fidati, lì al centro, ma lo possiamo travolgere con una carica».
La battaglia Il sole si è alzato da poco quella mattina quando i due eserciti si dispongono a specchio, divisi solo da un rivolo d’acqua. Gli Angioini attendono che gli Svevi attraversino il Riale per dar corso al loro piano, mettendo il ruscello alle spalle dei nemici e tagliando loro l’eventuale fuga. I Tedeschi stanno fermi, facendo lo stesso calcolo: preferiscono che a farsi avanti siano i Francesi, chiudendosi da soli la via di fuga.
Lo stallo viene deciso dalla presenza di un piccolo ponte di legno nei pressi di Castrum Pontis, l’unico punto in grado di garantire la fuga o l’inseguimento: gli Angioini decidono di prenderne possesso, gli Svevi fanno un finto tentativo di riprendere il ponte. E mentre sul passaggio si combatte, Enrico di Castiglia (cugino di Carlo d’Angiò, ma suo fiero avversario), seguendo un sentiero protetto dall’intricata vegetazione cresciuta sulle rive del Riale, «guadò arditamente il fiume alla testa de’ suoi valorosi soldati ed attaccò i Provenzali che furono ben tosto rotti, come pure poco dopo il corpo de’ Francesi». Gli Angioini sbandano, Henri de Courence si lancia nella mischia con le insegne regali. La schiera tedesca che combatte sul ponte aumenta la pressione e riesce ad avere la meglio dei francesi che scappano. Henri di Courance viene disarcionato e ucciso, le insegne di Francia sono a terra. Gli Svevi credono di aver vinto. Enrico di Castiglia si lancia all’inseguimento dei fuggiaschi, le truppe sveve si sparpagliano per la pianura in cerca di bottino. Corradino osserva tutto e ascolta i messaggeri che gli annunciano: «Re Carlo è morto, abbattuto insieme con le sue insegne».
«I Ghibellini erano talmente superiori di numero, che l’armata nemica si vide in breve distrutta o posta in disordinata fuga. Carlo che dall’alto di un colle vedeva l’uccisione delle sue genti, si disperava, e voleva ad ogni modo andare in loro soccorso, ma il signore di San Valerì, che perfettamente conoscendo la natura de’ Tedeschi aveva calcolati gli effetti della loro vittoria, non gli permise di muoversi». Lo scontro, però, non è finito.
La battaglia di Tagliacozzo fu un unicum rispetto alla tipologia degli scontri medievali. Fu una carneficina, senza rispetto delle regole cavalleresche, con prigionieri giustiziati sul posto e cavalieri massacrati anche quando si arrendevano. Fu una gigantesca imboscata, frutto del genio di Alardo di Valery, ma anche esempio di errato comando da parte di Corradino e dei suoi comandanti che non seppero tenere a freno la voglia di bottino dei loro uomini.
«La tendenza a spogliare subito i corpi degli uccisi, che era, come si è visto, duramente repressa dalle leggi bizantine perché distoglieva gli uomini dal combattimento, fu non di rado motivo di gravi sconfitte: basterà citare il famoso caso di Tagliacozzo dove nel 1268 Carlo d’Angiò battè Corradino di Svevia. Dopo il primo scontro – racconta Giovanni Villani – i Tedeschi si credettero di aver vinto e si cominciarono a spandere per lo campo, e intendere a la preda e alle spoglie, soccombendo così facilmente alla terza schiera che re Carlo aveva tenuto di riserva secondo i consigli di Alardo di Valery, maestro dell’oste e savio di guerra, il quale conosceva la cupidigia de’ Tedeschi e come erano vaghi delle prede»
Solo quando «Alardo di San Valerì vide compiutamente rotti gli ordini di battaglia delle truppe di Corradino, e che dispersi nell’inseguire i fuggiaschi, erano divisi in piccole bande, e non più in istato di sostenere l’urto della sua cavaleria, voltosi a Carlo, gli disse: “Fate adesso suonare la carica, che giunto è l’istante opportuno”».
Era arrivato il momento, per Carlo e le sue truppe nascoste, di attaccare. Fu così che «le truppe di Corradino, disordinate, esauste dallo strapazzo della mischia sostenuta e dall’inseguimento dei nemici fuggiaschi, avide di bottino ed intente al saccheggio, furono da quella piccola schiera di nemici atterrate, calpestate, disperse».
Carlo d’Angiò esce dal suo nascondiglio e coglie di sorpresa gli Svevi e con «freschi cavalieri» attacca i nemici «oppressi dalla fatica, e talmente dispersi, che in verun luogo trovavansi duecento cavalieri riuniti e disposti a fare resistenza, ne fecero uno spaventoso massacro». I cavalieri tedeschi, toscani e lombardi si accorgono del doppio inganno quando è troppo tardi. Impossibile riorganizzare le file e contrattaccare. Impossibile reggere l’urto di mille cavalieri lanciati contro nemici appiedati e intenti a spogliare cadaveri.
Neppure il ritorno di Enrico di Castiglia dall’inseguimento può fare nulla. Il cavaliere spagnolo riorganizza i suoi, tiene duro, cerca di riguadagnare la riva opposta del Riale, ma alla fine deve soccombere. «I Francesi, vedendo rialzata l’insegna del loro re, accorrevano ad ordinarsi intorno alla medesima, e per tal modo la gente di Carlo andava ingrossando, mentre scemava quella di Corradino».
Corradino assiste alla disfatta dalla terza linea, senza entrare mai in battaglia. Assiste impotente alla fine di una sanguinosa giornata che costa almeno quattromila morti e quasi altrettanti feriti. L’esercito di Corradino non esiste più, mentre quello di Carlo non è in grado di sostenere un’altra battaglia.
La fuga e l’esecuzione Il principe svevo cerca la salvezza a Roma, ma il clima politico è cambiato,adesso sono tutti angioini. Con Federico di Baden e pochi altri tedeschi e italiani fedeli raggiunge Astura, sulla costa a sud di Anzio, per salpare verso la Sicilia o Pisa, «ma Giovanni Frangipani, signorotto di Astura, fece inseguire i fuggiaschi con un rapido veliero, che li costrinse a tornare alla riva, ove furono rinchiusi nel castello. Con la promessa di denaro e di terre, il Frangipani consegnò i prigionieri agli emissari di Carlo d’Angiò». La prigione in Castel dell’Ovo e il patibolo lo attendevano. Corradino pagava per la giovane età, l’inesperienza, i cattivi consiglieri e «perché tutte le sue genti, sicure di aver già vinto, cominciarono a spogliare il campo e a bottinare, dando modo a re Carlo di irrompere con la sua schiera sui predatori e metterli in rotta».
Le suppliche e le preghiere della madre, Elisabetta di Baviera, non salvarono la vita al giovane, accusato di tradimento e lesa maestà. «Corradino trovavasi già tra le mani del carnefice; si staccò egli medesimo il mantello, e postosi in ginocchi per pregare, si rialzò gridando: “Oh mia madre, di quale profondo dolore ti sarà cagione la notizia che ti sarà portata della mia morte!”». Elisabetta di Baviera risponderà a questa preghiera tramite il poeta risorgimentale Aleardo Aleardi: «Nobile augello che volando vai, se vieni da la dolce itala terra, dimmi, hai veduto il figlio mio?”. “Lo vidi; era biondo, era bianco, era beato, sotto l’arco d’un tempio era sepolto”.
Ad Elisabetta riuscì solo di far traslare il corpo dell’ultimo sovrano svevo, dieci anni dopo la morte, nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Napoli dove «una statua di lui ed una pietosa iscrizione nella Chiesa del Carmine parlano del cordoglio di essa e le ricche dotazioni che lasciò a quei frati per suffragio dei suoi diletti». Una statua del giovane sovrano, voluta da Massimiliano di Wittelsbach, ideata da Bertel Thorvaldsen ed eseguita da Peter Schoepf nel 1847, decora il sepolcro di Corradino.

 Natale – Lo show room, l’expo all’Area di Servizi Civita Sud vi aspettano per presentare le nuove collezioni idee regalo per le festività 2019-2020. Pezzi unici per sorprendere e per essere apprezzati. Una amplissima scelta di articoli design particolari che fanno la differenza. Unitamente a ciò l’offerta si estende alla produzione diretta di Serafini Group: l’acetaia Serafini che da tradizione modenese autentica produce aceti balsamici D.O.P. con diverse tipologie di invecchiamento e con un sapore sopraffino ed unico con l’invecchiato 25 anni. Prodotto ideale per arricchire la tavola, sorprendere ospiti e palato. E poi il parmiggiano reggiano sempre di produzione Serafini che viene presentato in packaging Natalizio con stagionature di 24 e 30 mesi per un gusto sorprendente. E dunque val bene l’occasione di una visita: oltre 6000 metri quadrati via Colle San Giovanni a Civita di Oricola e/o presso l’Area di Servizio Civita Sud A24 nei pressi di Carsoli – Oricola.
Natale – Lo show room, l’expo all’Area di Servizi Civita Sud vi aspettano per presentare le nuove collezioni idee regalo per le festività 2019-2020. Pezzi unici per sorprendere e per essere apprezzati. Una amplissima scelta di articoli design particolari che fanno la differenza. Unitamente a ciò l’offerta si estende alla produzione diretta di Serafini Group: l’acetaia Serafini che da tradizione modenese autentica produce aceti balsamici D.O.P. con diverse tipologie di invecchiamento e con un sapore sopraffino ed unico con l’invecchiato 25 anni. Prodotto ideale per arricchire la tavola, sorprendere ospiti e palato. E poi il parmiggiano reggiano sempre di produzione Serafini che viene presentato in packaging Natalizio con stagionature di 24 e 30 mesi per un gusto sorprendente. E dunque val bene l’occasione di una visita: oltre 6000 metri quadrati via Colle San Giovanni a Civita di Oricola e/o presso l’Area di Servizio Civita Sud A24 nei pressi di Carsoli – Oricola.





















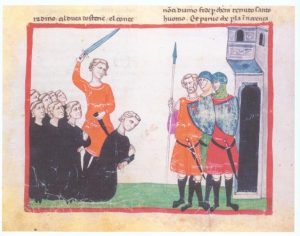 Il 29 ottobre del 1268 il sole splende su Campo del Moricino a Napoli. L’ultimo principe della casa di Svevia lascia Castel dell’Ovo e sale sul patibolo.
Il 29 ottobre del 1268 il sole splende su Campo del Moricino a Napoli. L’ultimo principe della casa di Svevia lascia Castel dell’Ovo e sale sul patibolo.



Commenti recenti